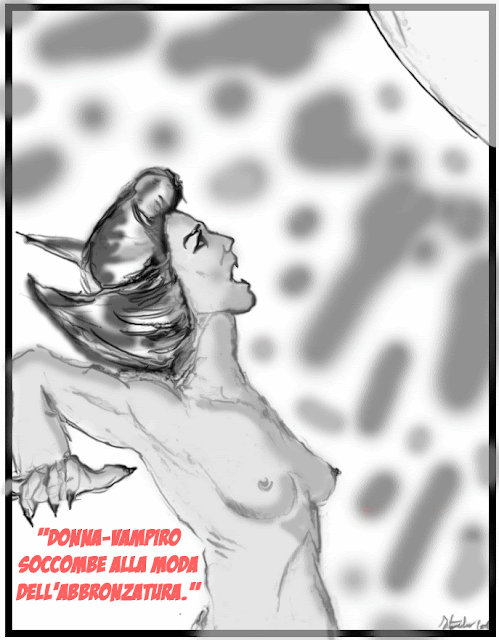(Difficoltà: 4,2/5)
La querela può diventare uno strumento
intimidatorio, e quindi antidemocratico, perchè può essere usata per inibire la libertà d'espressione e di denuncia.
La querela fa sì che la libertà di
parola sia subordinata al livello di censo: i tempi della giustizia
italiana e le alte parcelle degli avvocati costituiscono una
combinazione micidiale per chi non goda di benestare economico.
L'incertezza della pena si declina poi in una duplice forma a
offuscare ulteriormente il quadro: chi mi dice che chi ha i soldi per
tenere per anni a libro paga un avvocato non li abbia anche per
comprarsi la sentenza? Non viviamo dopotutto in uno dei paesi più
corrotti al mondo? E: ammesso che io abbia ragione e il giudice
confermi, al terzo grado di giudizio – cioè dopo anni - , che i
reati che ascrivevo al querelante sono reali, cosa rischia questi
veramente rispetto a quello che rischio io, considerati i vari indulti, gli sconti di pena e il
perdonismo di una legislazione penale fatta dai colletti bianchi per
i colletti bianchi?
La Legge Nasce per Tutelare i Deboli, Non i Forti
La legge è nata per i deboli, non per
i forti. Per i forti già esistono le leggi di natura (dove
all'ereditarietà dei tratti somatici nel regno umano si affianca
l'eredità patrimoniale e di status sociale), che li privilegiano. Ne
consegue che la legge non deve essere imparziale, bensì seguire la
sua vocazione nel porsi a tutela della parte offesa. Resta inteso che
il “debole” è colui che ha subito il torto in una specifica
occasione, e quindi il concetto non definisce per principio e in
partenza una condizione sociale o di censo.
I problemi strutturali del sistema
giudiziario italiano – afferenti in pari tempo a questioni
amministrative e legislative – implicano purtroppo la creazione di forti
squilibri. Come impedire, quindi, che anche le querele per ingiuria o diffamazione non diventino
espedienti intimidatorii in grado di interferire con la libertà di
cronaca e di opinione?
Con la naturale premessa che le
lentezze e le storture del nostro sistema giudiziario hanno una
ragione d'essere nella gaglioffaggine della nostra classe dirigente,
la principialità della Costituzione potrebbe forse offrire leva per
insenature interpretative del codice e richiamare così concetti come
la “verosimiglianza” del giudizio apparentemente lesivo, la fondatezza di questo in
accadimenti precedenti ecc. A titolo di esempio, la querela a seguito
di un'accusa giornalistica, anche qualora questa non fosse sorretta
da prove decisive, dovrebbe essere rigettata in nome dei principi di
libertà e di verità ricavabili dalla Costituzione. L'attribuzione
di un fatto dovrebbe fungere da stimolo per gli organi di informazione e
di giustizia per far luce su eventuali responsabilità, in ragione di
un criterio di trasparenza perfettamente afferibile ai principi della
libertà d'espressione e di parola.
La semplice constatazione di una
pregiudiziale nell'inizio di una causa per diffamazione - alla luce
per es. di un semplice criterio di verosimiglianza della
dichiarazione presuntivamente lesiva - dovrebbe inibire l'avvio del
procedimento, se non per accertare la veridicità delle attribuzioni
e quindi il valore testimoniale delle attribuzioni emerse, decidendo
così per il luogo a procedere ovvero per un obbligo di rettifica. Il
giudice dovrà valutare già in sede preliminare la buona fede del
querelato, cioè la sua intenzione o meno di ricercare la verità.
Per questioni minori quali scaramucce o
insulti, spontanei ovvero poco o per nulla legati a fatti specifici,
il giudice dovrebbe – come per altre situazioni simili –
subordinare la questione a un criterio economico e di censo: se la
parte lesa ritiene che la propria dignità in casi triviali le
valga più delle spese legali, può chiedere e ottenere giudizio.
Solo in caso di evidente disparità economica a vantaggio del
querelato si dovranno disporre provvedimenti risarcitori e il rimborso totale delle spese legali,
qualora si riscontrasse l'infondatezza delle attribuzioni. E' il caso,
per es., di un datore di lavoro che insulti un dipendente. Il pagamento delle proprie spese legali, per converso, dovrebbe essere sufficiente punizione per il querelato condannato/soccombente, quando questi ricopra un livello economico-sociale significativamente inferiore rispetto al querelante.
Una giustizia che si possa ritenere tale deve tener conto dei soprusi e storture generati da un consistente divario nei rapporti di forza.
Una giustizia che si possa ritenere tale deve tener conto dei soprusi e storture generati da un consistente divario nei rapporti di forza.
Conclusione
In conclusione, la giungla delle
denunce per diffamazione - strumento particolarmente in voga fra politici interessati a imbavagliare la stampa - potrebbe essere fatta uscire dallo “stato
di natura” in cui versa – e in cui scade a strumento di
sopraffazione del forte sul debole – rendendo il concetto “feudale”
di “onore” (non a caso caro alla mafia) qualcosa di gregario
rispetto ai principi civili e costituzionali della libertà, della
verità e della trasparenza, gli unici in grado di decidere sulla fondatezza di certa onorabilità.